Santuario Madonna della Bassa RUBIANA (TO) - Mompellato
Accesso: Il santuario della Madonna della Bassa si raggiunge percorrendo la provinciale per il colle
del Lys e si trova in prossimità del valico, a 1152 m di altitudine, sullo spartiacque tra le valli Susa e
Casternone.
In auto si percorre l’autostrada A 32, Torino-Bardonecchia, uscendo ad Avigliana Ovest per proseguire lungo la
provinciale n. 197 in direzione Rubiana-Colle del Lys e, superata la frazione Mompellato, si prosegue ancora per
poche centinaia di metri fino al bivio che compare sulla destra. Il Santuario dista circa tre chilometri.
Da Val della Torre si raggiunge invece, a piedi, con un sentiero che comincia appena a monte della borgata Lucco.

Il Santuario della Madonna della Bassa, dedicato alla Vergine Addolorata, sorge in una splendida conca ricca di
boschi di faggio e larice che conduce al colle del Lys, storico valico tra le valli di Susa e di Viù.

L’edificio e il culto a esso legato risalgono all’epoca moderna e originano da un pilone eretto come ringraziamento
per ben due miracoli avvenuti il 18 agosto 1713 e il 20 agosto del 1714.
Il beneficiario di entrambi i prodigi fu un certo Lorenzo Nicol, che il 18 agosto 1713 era salito nella faggeta
per raccogliere legna. Una volta assemblate le fascine, l’uomo si era caricato in spalla il pesante fardello e
aveva iniziato la discesa ma il terreno scosceso e umido lo tradì. Un piede appoggiato malamente, la caduta e il
povero Nicol si ritrovò immobilizzato in quel luogo sperduto, lontano chilometri dalla prime baite e con una gamba
fratturata.
Disperato, l’uomo si rivolse in preghiera alla Madonna invocandone l’aiuto e promettendo di costruire un pilone
in suo onore in quello stesso luogo. La preghiera venne esaudita e la gamba improvvisamente guarì.
Il Nicol però non mantenne la promessa e riprese la sua normale attività finché il 20 agosto dell’anno successivo,
ancora una volta gravato dal carico di fascine, cadde nello stesso luogo spezzandosi nuovamente una gamba. Solamente
in quel momento il malcapitato si rese pienamente conto della sua mancanza e, dopo aver domandato perdono,
pur con estremo imbarazzo pregò unl’altra volta la Madonna di concedergli la grazia della guarigione. E la Vergine
misericordiosa gli apparve nuovamente esaudendo la sua preghiera.
Questa volta il Nicol non dimenticò la promessa e il giorno appresso iniziò la costruzione del pilone trascorrendo
poi il resto della sua vita (morì nel 1765) a diffondere la devozione mariana in zona.
La notizia dei miracoli si diffuse rapidamente e sul luogo, in cui il Nicol aveva anche collocato la statua
della Vergine che oggi si venera custodita nella nicchia del presbiterio, cominciarono ad affluire fedeli sempre
più numerosi. Così nel 1721, appena sette anni dopo la sua costruzione, il pilone venne sostituito da una cappella
che in seguito venne più volte ampliata, finché nel 1845 assunse l’aspetto attuale, anche se gli ultimi
ammodernamenti risalgono alla fine del `900.
Oggi infatti il complesso si compone di una costruzione, adibita a diverse funzioni, e un corpo unico costituito
da un fabbricato in grado di ospitare una ventina di pellegrini, unito alla chiesa vera e propria. Questa, pur
non palesando particolari pregi architettonici, è preceduta da un porticato e strutturata in tre navate
una delle quali si trova in territorio di Val della Torre, mentre le altre due sorgono nel comune di Rubiana.


Delle tre navate in cui si articola l’interno, la più antica delle quali è quella di sinistra e corrisponde
alla primitiva cappella costruita nel 1721. Interessanti gli affreschi del presbiterio, opera di Francesco Tabusso
e Germana Albertone, importanti e noti artisti della zona. Le tre scene rappresentano al centro il Miracolo
della grazia a Lorenzo Micol e, ai lati, le Suore Francescane Missionarie di Susa, con Monsignor Rosaz, e le
Suore della Beata Michelotti.


Miracolo della grazia a Lorenzo Micol

Suore Francescane Missionarie di Susa, con Monsignor Rosaz

Suore della Beata Michelotti
Particolarmente interessanti sono i 323 ex voto che ornano le pareti delle navate laterali del Santuario e
illustrano le innumerevoli grazie elargite dalla Madonna della Bassa. Strumenti efficacissimi attraverso i quali
arriva alla collettività il messaggio della sofferenza e del suo successivo sollievo, narrano storie di guarigioni
di uomini e animali (a dimostrazione dell’importanza del bestiame in unl’economia che superava di poco la pura
sussistenza), disgrazie, incidenti, fatti giudiziari, riconciliazioni e guerre (d’Africa, e delle due guerre
mondiali).
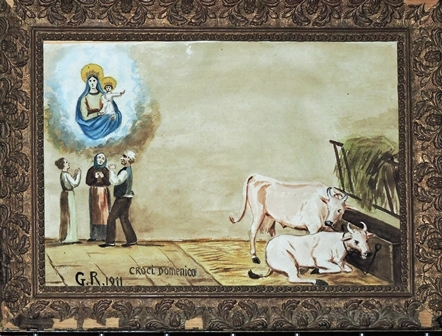





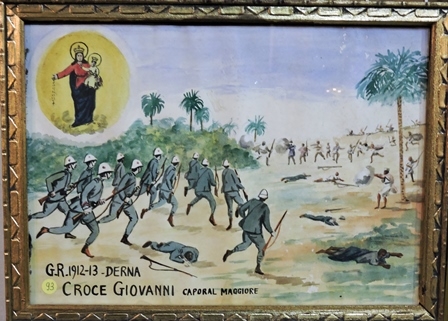
Ma il più antico, e senza dubbio artisticamente pregevole tra i quadri, è l’ex-voto che raffigura l’evento
miracoloso del 19 maggio 1817. In quei mesi in Italia imperversava unl’epidemia di tifo petecchiale, considerata
una vera pestilenza, che colpiva uomini e animali. Disperate, le genti di Rubiana, Val della Torre e dei paesi
vicini si radunarono a Mompellato e salirono in processione al Santuario per domandare alla Madonna la fine
dell’epidemia. Le loro preghiere vennero esaudite e quando furono in vista del Santuario, cominciò a cadere
una pioggia purificatrice che fece cessare il contagio. Da allora la processione si ripete ogni anno il giorno
dell’Ascensione.

Processione del voto
Il Santuario è anche un punto di riferimento di uno dei percorsi dell’Ecomuseo della Resistenza del Colle del Lys,
che in queste zone ha scritto pagine gloriose e tragiche della storia italiana, poichè proprio alla Madonna
della Bassa i garibaldini si riunivano per l’ "ora politica", come definivano i momenti di riflessione sulla
storia e di analisi della situazione della lotta antifascista.
Il Santuario non è aperto al pubblico e per visitarlo ci si può rivolgere al parroco di Rubiana telefonando
allo 011-9358916. Durante l’anno si tengono due festeggiamenti in onore della Madonna della Bassa
(la 3" domenica di agosto e la 3" domenica di settembre) mentre alla Festa dell’Ascensione si tiene la solenne
processione che da Mompellato raggiunge il Santuario in ringraziamento del "Miracolo dell’acqua" del 1817.
Natura e resistenza al colle del Lys
Dal 2004 la sommità del colle del Lys è unl’area naturale protetta gestita dalla Provincia di Torino,
che comprende i versanti nord-occidentale e sud-occidentale del monte Arpone (1310 m), a est del valico, e la zona
a monte della strada di accesso al Santuario della Madonna della Bassa (1152 m) che ne rappresenta l’estremo
limite meridionale. La zona presenta una vegetazione varia, con zone a brughiera e bassi cespuglieti, alternate a
boschi di larice, abete rosso e faggi alle quote più basse. Inoltre nella parte settentrionale del parco
si trova una delle pochissime stazioni note (unl’altra, poco distante, è il monte Lera) di un raro endemismo
vegetale, l’Euphorbia gibelliana, specie descritta nel 1892 dal geologo-naturalista Paolo Peola che l’ha dedicata
al professor Giuseppe Gibelli, allora direttore dell’Orto Botanico di Torino. Il parco è poi particolarmente
interessante poiché si trova su una importante rotta migratoria degli uccelli.
Dopo l’8 settembre 1943, nella zona compresa tra il vallone del Lys e Mocchie (sopra a Condove in bassa val Susa)
si insediò la 17" Brigata Garibaldi "Felice Cima", comandata da Alessio Maffiodo, di cui faceva arte anche il
distaccamento femminile "Anita Garibaldi". Questo era formato da partigiane che svolgevano lavori di sartoria,
effettuavano servizi di staffetta e parteciparono ai combattimenti in caso di bisogno.
Il colle del Lys fu teatro di un infame episodio operato dai nazifascisti al termine dei durissimi scontri
dell’1 e 2 luglio 1944. Oltre ai caduti in battaglia, 26 garibaldini caddero nelle mani degli occupanti che
dopo averli torturati, li trucidarono vigliaccamente. Oggi sul piazzale del colle è stato costruito un monumento
alla memoria e, dal 2000, è allestito un Ecomuseo della Resistenza.
Il monumento ai caduti è una torre di forma circolare. Eretto nel 1947 come semplice cippo con unl’iscrizione e
una lapide, fu poi costruito come torre di mattoni otto anni dopo, nel 1955, e infine ristrutturato nel 1977
con rivestimento in pietre a vista. Queste sono 2024, lo stesso numero dei caduti delle quattro valli circostanti,
da cui provengono: 718 in val Susa, 704 nelle valli di Lanzo, 422 in val Sangone e 180 in val Chisone.
L’Ecomuseo ha una sede documentale ma la sua ragion d’essere sta nei luoghi circostanti, dove si possono ritrovare
i segni della resistenza partigiana attraverso 6 percorsi che si snodano nella zona.
L’Ecomuseo è aperto tutte le domeniche dal 25 aprile all’8 settembre, dalle 10 alle ore 18. Per scolaresche o
comitive sempre, su prenotazione.
Nella prima domenica di luglio e nella domenica più prossima all’8 settembre si svolgono grandi manifestazioni
commemorative.
©PIEMONTESACRO.IT. Tutti i diritti riservati.
Testo e foto di Gian Vittorio Avondo.

Ciao,
mi chiamo Stefano.
Piemonte Sacro è la mia passione dal 2001.
AIUTA il progetto Piemonte Sacro a crescere
DONA SOLO 2 euro! Te ne sarò GRATO .




